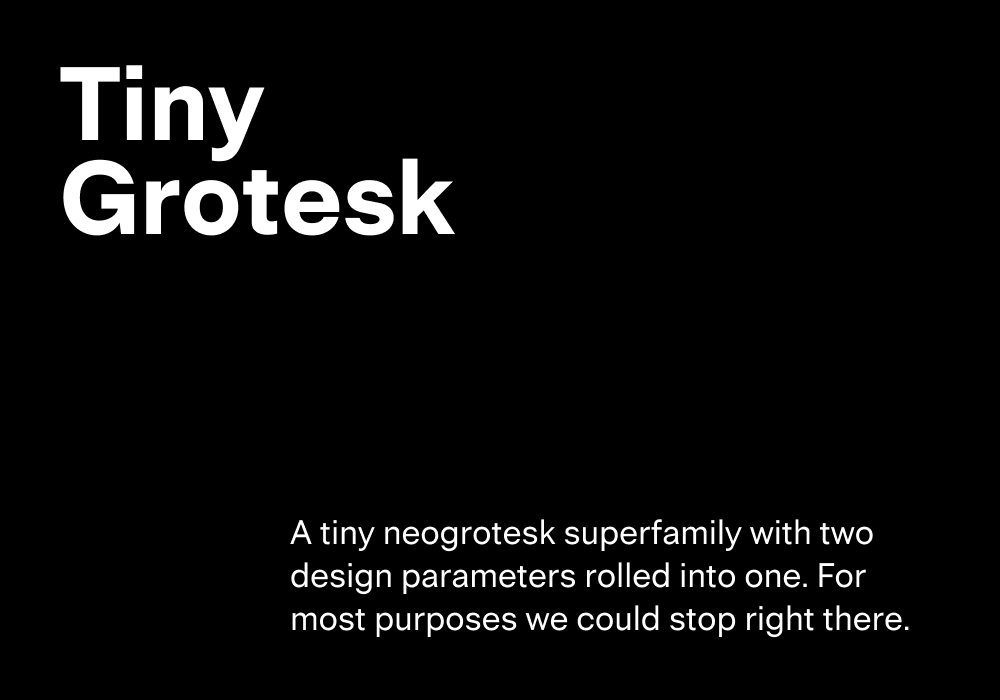#078 — Espressione e comprensione 10/11/2025
Questo numero prosegue la riflessione sull’espressione, spostando l’attenzione sulla comprensione. È importante che ci si capisca, nel design e non solo.
Per ricevere Dispenser.Design via email iscriviti qui.
Espressione e comprensione
Nello scorso numero si parlava di espressione e funzione nel design, e di come la ricerca aiuti a individuare una direzione in entrambi i casi. Forse però ho dato per scontato che l’espressione, per funzionare, debba essere comprensibile.
Ci ho pensato quando un mio studente mi ha mostrato il lavoro che stava facendo per il suo portfolio. Alcune proposte le aveva scartate perché, diceva, erano troppo simili ai soliti portfolio. La sua preferita era una pagina web che simulava l’interfaccia di un sistema operativo. Diceva che lo rappresentava meglio. Ho avuto però la sensazione che si fosse affezionato all’idea, convinto fosse molto originale. Gli ho detto che non lo era1, ma il problema non era l’originalità, piuttosto il fatto che non si capiva chi fosse e cosa facesse.
L’altra volta avevamo riportato una citazione di Enzo Mari: «senza ricerca critica, ogni linguaggio finisce per diventare convenzione». Ma senza l’utilizzo di codici condivisi il rischio è parlare solo a se stessi. Come osserva Milton Glaser, «when art and design are confused, the designers’ domain becomes limited to style and appearance»2.
Nel 1988, Jorge Frascara3 criticava alcune avanguardie per la loro eccessiva autoreferenzialità nell’articolo Graphic Design: Fine Art or Social Science? (apparso su Design Issues, una pubblicazione accademica del MIT). A un certo punto scrive: «Per quanto tempo ancora continueremo a celebrare El Lissitzky?»4. L’intento non era mettere in discussione la storia del design, ma criticare una celebrazione della forma svincolata dalla comunicazione effettiva.
Sembra che non si siano resi conto che la comunicazione richiede la condivisione di codici. Anche se i designer non devono fare totale affidamento sugli stereotipi, non possono ignorare i codici del pubblico: dovrebbero lavorare con il pubblico e migliorare il suo linguaggio visivo e concettuale il più possibile, senza però rompere il legame comunicativo.
In pratica, l’espressione è efficace se il pubblico a cui è destinato lo capisce.
Nel 2022, Frascara riprende l’articolo del 1988 e scrive Revisiting “Graphic Design: Fine Art or Social Science?” – The Question of Quality in Communication Design. Torna su alcuni temi del primo articolo, spostando però l’attenzione sull’eccessiva semplificazione e sul rischio di farsi guidare da procedure, framework, template, automatismi. E nel 2022 ancora non si era diffuso ChatGPT. La qualità progettuale, scrive, si misura spesso in velocità; l’efficacia comunicativa coincide con la riduzione, e la complessità diventa un difetto.
Il ruolo del designer non è semplificare la complessità, ma organizzarla a livello concettuale e renderla accessibile.5
Un tema simile era emerso nel numero scorso, dove si riprendeva un articolo di Jarrett Fuller che scriveva come «gran parte del graphic design oggi è stato automatizzato e standardizzatp al punto da sembrare già il prodotto di un sistema di intelligenza artificiale»6. Stessi font, stessi colori, stessi layout.
Forse l’eccessiva semplificazione e conformità potrebbero far riemergere forme di autoreferenzialità. Negli anni Novanta è successo qualcosa di simile. Quando l’avvento del computer (e del desktop publishing) sembrava minacciare la professione, i designer reagirono con una stagione di sperimentazione radicale (vedi April Greiman, David Carson) provando a riscrivere i codici del linguaggio grafico7.
Bisognerà ricordarsi di nuovo che oltre la novità stilistica è importante considerare l’impatto di quel design sul pubblico a cui è rivolto. Se quel design attua un cambiamento, nella conoscenza, nel comportamento o negli atteggiamenti.
Nello scorso numero si parlava di funzione in riferimento perlopiù all’interazione di un utente con un’interfaccia e all’attività da svolgere, ma, promemoria (anche per me), la funzione è anche legata alla comprensione, non solo all’azione e all’esecuzione.
-
Una notevole esecuzione dell’idea di un sito informativo che si ispira al design di un sistema operativo è il sito di Posthog. ↩︎
-
Anne Quito, “Design has nothing to do with art”: Design legend Milton Glaser dispels a universal misunderstanding, Quartz, 2022 ↩︎
-
Docente e designer argentino, ora in pensione. Ha insegnato per molti anni all’Università di Alberta in Canada. ↩︎
-
Jorge Frascara (1988), Graphic Design: Fine Art or Social Science? Design Issues ↩︎
-
Jorge Frascara (2022), Revisiting “Graphic Design: Fine Art or Social Science?” – The Question of Quality in Communication Design, She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation ↩︎
-
Jarrett Fuller, AI isn’t design’s biggest problem, Fast Company, 2025 ↩︎
-
Sto riprendendo di nuovo questo articolo: Jarrett Fuller citato nella nota precedente. ↩︎
Tiny Grotesk →
Tiny Grotesk è un carattere tipografico della fonderia Tiny Type Co. Come scrivono sul loro sito, il progetto unisce la tradizione svizzera del XX secolo con l’eredità calligrafica italiana del Cinquecento.
Riprende la chiarezza formale di font come Helvetica, Univers e Folio, ma introduce nelle versioni Narrow un ritmo testuale che riprende le proporzioni dei corsivi di Aldo Manuzio e Ludovico Arrighi.
Tiny Grotesk è strutturato in tre sottofamiglie che corrispondono anche a tre dimensioni ottiche d’uso: Narrow per corpi piccoli (con ink trap e ottimizzazioni per la leggibilità), Regular per applicazioni generali, e Wide esclusivamente per titolazioni di grande dimensione, con spaziature strette e contrasti di tratto esasperati.
La famiglia comprende dodici stili, quattro pesi per ciascuna larghezza.